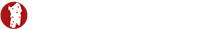Che si sia di fronte nuovamente ad una “questione sarda”, come problema dell’arretratezza economica dalla nostra Isola, non vi possono essere molti dubbi. Certo, rispetto a quel che sostenevano in passato il Tuveri ed il Lei-Spano, appare forse mutata la sua sostanza, ma ne rimangono sostanzialmente immutate le distanze dalle regioni continentali in tema di progresso e benessere generali. In più sembrerebbe essersi ancor più aggravata la dipendenza dalle economie esterne per via d’una bilancia commerciale che vede le importazioni prevalere nettamente sulle esportazioni, determinando un’effettiva sudditanza dalle risorse e dai trasferimenti provenienti dall’esterno.
Quel che assimila comunque le due condizioni sta proprio in quel comune riferimento ai ritardi su quel che avviene all’al di là del mare, come raffronto, subordinazione ed inferiorità. Perché, ora come allora, si è determinata quella distanza che gli economisti di scuola anglosassone definiscono backwardness, cioè arretratezza economica.
Un ritardo che era già stato affrontato un secolo fa con le leggi “speciali” del ministro Cocco-Ortu e, successivamente, con la legislazione “straordinaria” della Casmez e della Rinascita: un obiettivo, peraltro, lasciato incompiuto, o mancato, anche perché punteggiato da frequenti fermate e deviazioni. Per cui oggi è certamente corretto sostenere che continui a permanere una “questione sarda” da affrontare, in modo da colmare quell’attardamento che penalizza e mortifica lIsola nei confronti delle economie continentali.
Proprio Pietrino Soddu, autorevole politico della stagione della Rinascita, ha sottolineato recentemente, in un suo lucido intervento, come continui a permanere l’attualità della “questione”, come segnale del forte distacco esistente, in termini di progresso, tra la Sardegna ed il resto del Paese. Perché, a suo giudizio, nell’Isola si va aggravando «la dipendenza mentre è diminuita l’autonomia in tutti i campi, con la perdita del controllo dell’apparato bancario e del sistema informativo, e con il progressivo indebolimento delle classi dirigenti e della specificità delle sue strutture economiche. Con il pericolo di divenire sempre più una passiva destinataria delle decisioni altrui».
Infatti, a causa della perdita di questi fondamentali asset socio-economici, la “questione” va assumendo, per noi sardi, il carattere di un handicap di natura strutturale che, se non affrontato decisamente, continuerà a condizionare pesantemente il nostro futuro prossimo venturo. Proprio perché oggi, assai più di ieri e ieri l’altro, ha posto di fronte i fattori più antichi e resistenti della tradizione isolana (quelli che si identificano in “su connottu”) con i grandi mutamenti di una incalzante modernità avvenuti nel mondo. Una contrapposizione che ha provocato, e continua a provocare, dei gravi ritardi nell’inserimento dell’economia sarda nel grande scacchiere di mercati divenuti sempre più globali e competitivi. Quasi che l’economia sarda intenda affrontare i suoi competitors economici forniti di micidiali bazooka e kalashnikov con i soli suoi antiquati fucili “modello ’91” e le inutili “guspinesi”. O che la nostra massima velocità verso il progresso sia rimasta quella lumacosa del nostro “pendolino” in raffronto con quella delle gazzelle continentali del tipo “freccia rossa” o TGV francese!
Infatti, l’economia sarda continua a soffrire di una cronica lentezza nell’innovarsi e nel progredire. Perché continua a ricercare un ritorno ad antiche felicità aurorali (mai esistite) nella mitica e fantasiosa Ichnusa, in alternativa all’esigenza di dover realizzare innovativi modelli di civiltà assai più prodighi di benessere sociale. Basti pensare che il reddito medio di un sardo è oggi poco più della metà d’un lombardo e che il nostro Pil per abitante (cioè la capacità di produrre ricchezza) diventa sempre più distante da quello medio del Paese, avendo allungato il distacco di oltre 10 punti percentuali sul dato degli anni ’80.
C’è stata invero della crescita sul fronte dei consumi, ma al di fuori del sistema produttivo, come andamento in progressione del redditi individuali, per via principalmente dell’espansione abnorme del pubblico impiego, passato da 1,5 a 3,4 dipendenti ogni 10 sardi, e della distribuzione commerciale, che ha più che doppiato i suoi organici, sfiorando il 47 per cento. Un’evidente dicotomia rispetto ad agricoltura e industria che avrebbero visto invece diminuire di un terzo abbondante i propri addetti, oggi a non più di 1,9 occupati ogni 10 sardi. A conferma di quel “dipendentismo” strisciante che pare essere oggi il maleficio principale della nostra “questione”.
I germi che l’hanno provocato sono essenzialmente due: il primo può essere individuato nell’isolamento geografico, cioè nelle forti diseconomie che penalizzano di un buon 25-30 per cento il reddito delle imprese produttrici sarde nei confronti dei loro competitors continentali; il secondo, ma non proprio un second-best, nel progressivo decadimento delle sue classi dirigenti, ovunque siano situate: nella politica, negli affari, nel sindacato e nella cultura. Ci sarebbe poi, come aggiunta, il fatto che i centri decisionali degli attuali agenti di sviluppo, da quelli finanziari a quelli industriali, siano locati ormai tutti al di fuori dell’isola. Per cui oggi i problemi sardi vengono affidati a soluzioni assunte a Modena o a Milano, come a Roma o a Zurigo o Mosca, da personaggi spesso molto “distratti o disattenti”, di fatto lontani, anche per proprio interesse, da quel che serve all’Isola.
È anche questo l’effetto di quel “dipendentismo” vizioso che va caratterizzando e mortificando l’economia isolana, e che è la controfaccia, o l’opposto, di quelle capacità d’autogoverno e di autosviluppo che erano state il sogno, e la speranza, di una pattuglia di grandi nostri conterranei, da Attilio Deffenu a Camillo Bellieni e a Emilio Lussu. E che s’era poi realizzato con quell’Autonomia “speciale” conquistata poi, tra non poche difficoltà e diffidenze, proprio ottant’anni or sono all’interno della Costituzione repubblicana.
Per risolvere la “questione” occorrerebbe quindi fare ricorso ad una nuova ingegneria politica dello sviluppo, che sia capace di rimuovere quei vincoli a cui s’è fatto prima riferimento. Innanzitutto affrontando il problema dell’insularità che non è soltanto un problema di mobilità facilitata per persone e merci: è un problema, anche e soprattutto, di sottocultura, nel senso che richiede, per superarlo, di un’infusione massiccia di conoscenze, di risorse e di virtuose “connection” con centri esterni di produzione e di ricerca.
A seguire vi è la debolezza e l’inadeguatezza delle classi dirigenti, ed è certamente il problema più grave. S’impone la volontà di dover cambiare, o almeno di tentare attraverso alcuni passaggi: selezionando innanzitutto delle élite che abbiano alto il senso della responsabilità civica e del rigore etico prima che il tornaconto privato e l’ossequio verso i politici; facendo sì che le selezioni premino competenze e meriti e non favori clientelari o furbizie varie; riportando ancora nella società economica dell’isola il primato del profitto da attività d’impresa nei confronti delle rendite da contributi e aiuti pubblici; liberando infine le imprese dall’infeudamento politico e dalle tagliole burocratiche degli aiuti c.d. “a bando” e dalle rendite di posizione più o meno clientelari.
La “questione sarda” in questo XXI secolo consiste proprio nell’aggravarsi di quella condizione di dipendenza (che è l’opposto dell’autonomia proclamata in statuto) che penalizza oggi l’isola e precarizza il suo futuro: per affrontarla e superarla occorre agire su più fronti, ad iniziare da quel che appare come il male più pericoloso: la mediocrità delle sue élite di comando, della politica, dell’economia, delle libere professioni e della cultura.
Soddu ritiene che occorra prendere atto che si sia ormai giunti ad una fase che chiama “post-autonomistica”, nel senso che negli ultimi sessant’anni la Sardegna è profondamente cambiata, e con essa dovrebbe modificarsi radicalmente anche l’impostazione ed i contenuti della politica regionale. Per cui ritiene necessario che le classi dirigenti prendano atto delle mutazioni avvenute ed agiscano di conseguenza, adottando soluzioni coerenti con le nuove esigenze ed i nuovi contenuti dettati dal progresso. Propone quindi la necessità di aprire un negoziato con lo Stato per definire un nuovo “patto costituzionale” che possa rappresentare il superamento dell’attuale Statuto del 1948. Fondato quindi su «nuove norme, regole, procedimenti, strumenti e soprattutto istituzioni pensate e costruite secondo il principio di una “sovranità federale”, di una “sovranità condivisa”, per poter partecipare pienamente alla “seconda modernizzazione” in corso nel mondo».
Si possa condividere o meno quest’indicazione, quel che appare necessario ed urgente è la predisposizione di una nuova “cassetta degli attrezzi” istituzionali, in modo da poter intervenire per risollevare le malconce sorti di questa nostra Sardegna. Perché lo scenario nazionale ed internazionale che si ha davanti in questo 2018 è ben differente da quello del 1948, e le “specialità autonomistiche” di allora paiono ben poca cosa di fronte alle complessità sociali ed economiche di questa seconda modernizzazione in atto nel mondo. All’interno di questo scenario, una nuova ed importante responsabilità compete alle nostre classi dirigenti, dovunque siano collocate: a loro spetta l’ideazione e la predisposizione di idonee proposte operative che affrontino decisamente, e sconfiggano definitivamente, quell’antico maleficio, che incombe sulla Sardegna, d’essere sempre più colonia: ieri politica ed oggi economica. Serva e suddita, comunque, di decisioni, di voleri e di interessi esterni.
Paolo Fadda
Economista, saggista, già dirigente del Banco di Sardegna