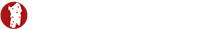“Perché l’ho fatto? Perché tra scegliere di stare a parlare su determinate cose, oppure farle, ho scelto di farle”. Karim Franceschi – padre italiano, madre marocchina – aveva 25 anni quando prese quella decisione: combattere per strappare Kobane all’Isis. Racconta così al telefono, con la voce pacata, mentre sta partendo per Cagliari, dove questa domenica, appuntamento alle 20 nello spazio ‘Villaggio Chourmo’ allestito in viale Regina Elena, racconterà al festival di letteratura Marina Cafè Noir la sua storia e il libro che ne è nato: Il combattente, scritto per Rizzoli con l’aiuto di Fabio Tonacci, il giornalista de “La Repubblica”, conosciuto proprio sul fronte in Kurdistan. L’esperienza di Franceschi approderà anche al festival del Cinema di Venezia: venerdì sarà presentato, fuori concorso, il documentario, ‘Our War’, di Claudio Jampaglia, Benedetta Argentieri e Bruno Chiaravalloti che racconta la storia di tre combattenti anti-Isis.
Karim sembra quasi più grande di quello che appare, forse anche perché un’esperienza simile fa crescere in fretta, volenti o nolenti, forse perché ha con se un bagaglio ideologico complesso, da cui traspare una passione politica nata e alimentata dalle frequentazioni nei centri sociali nelle Marche, dove vive tutt’ora. Poi lo guardi in foto e vedi la faccia di un giovane ed è un contrasto ancora più forte, perché viene ancora più difficile immaginare come possa aver deciso di imbracciare un fucile e andare combattere prima nelle milizie dell’Ypg e poi come cecchino. Se il libro esiste è anche per cercare di mettere ordine a tutto ciò, esorcizzare una esperienza simile e allo stesso tempo fare in modo che i coetanei di Karim capissero le motivazioni più vere di quanto gli è accaduto.
Dalle sue parole traspare questa urgenza fortissima: “Volevo raggiungere quelli della mia età – spiega Karim – Volevo raccontare quella resistenza e riaccendere quello stesso fuoco che i nostri padri, i nostri nonni partigiani hanno vissuto”. Il riferimento alla guerra di liberazione dal nazifascismo non è un vezzo politico ma una questione di cuore: suo padre, Primo, quando più o meno aveva gli stessi anni di Karim, aveva fatto il partigiano nelle montagne toscane nella compagnia “Marcello” e proprio “Marcello” è il nome che si è dato Karim da soldato. Un nome da battaglia che, insomma, porta con se, oltre agli ideali anche gli affetti più cari.
“L’Isis inoltre non è molto diversa dal nazismo o dal fascismo, nel senso che hanno in comune la disumanizzazione dell’essere umano. – continua – Primo Levi racconta molto bene proprio questo aspetto. Una volta che l’uomo viene ridotto in questo modo, ogni crimine nei loro confronti non è più tale. Vedi ad esempio cosa è successo agli Yazidi, che l’Isis chiama ‘kuffar’ (letteralmente ‘miscredenti’, ndr.). Sono stati uccisi dalle milizie di Daesh, mentre le donne sono state trasformate in schiave sessuali”.
A Kobane, Karim ci arriva nell’inverno del 2014, è in Turchia in una missione umanitaria in quella parte di Kurdistan gestito dal Royava che si basa non sulla necessità di avere una nazione curda, ma bensì una forma di confederazione democratica, basata su una visione solidarista, ma allo stesso tempo laica e femminista della società. È una zona di confine caldissima, a ridosso del fronte con un vai e vieni incessante di persone. In un campo profughi a Soruc incontra due bambini soldato con ancora la paura negli occhi. È quello sguardo a far scattare in Karim la necessità di dover fare qualcosa. Così poco dopo valica di nascosto la frontiera con la Siria: “Non è stato semplice, – racconta – bisognava muoversi di notte per eludere il blocco alla frontiera turca, saltando il filo spinato tra i campi. E poi correre e correre, seguendo un contrabbandiere come guida. Rischiavo molto: dall’arresto da parte dei turchi, sino a poter sbagliare strada e finire prigioniero dell’Isis”.
Una volta in Siria, i soldati dell’Ypg lo interrogano, vogliono capire chi sia e soprattutto se non sia una spia. Riesce a conquistarsi la loro fiducia e finisce in un campo di addestramento. Sono tutti giovanissimi: “Anzi, io per certi versi ero il più anziano – evidenzia Karim – gli altri avranno avuto sui 16 o 17 anni. C’erano anche delle ragazze”. Non è l’unico occidentale lì in guerra, ci sono anche un americano e uno spagnolo, ma vedrà di sfuggita solo il primo, ed è comunque l’unico italiano. Quattro giorni dopo è in prima linea con un AK47 in mano: “Sul fronte avevano bisogno di rimpiazzare uno che era rimasto ferito, così mi hanno chiesto se ero disponibile. Gli ho fatto capire che ero capace e sono andato”.
Sono i giorni più duri dell’offensiva con le due parti fisse a contendersi la collina di Mishenuk. Da lì dipende il destino di Kobane. “Com’ero? Come facevo? Diciamo che, diciamo che… con i compagni ci prendevamo cura l’uno dell’altro, ecco”. Lì su quel colle ci rimane un mese, poi lo spostano, quando parte della città viene liberata, piano piano, sino alle campagne. “Se avevo paura di morire? Sì, quando sono arrivato non era per niente sicuro che potessimo riprendere la città, non sapevamo cosa sarebbe potuto accadere. Avevo anche scritto una lettera nel caso le cose fossero andate per il peggio”. Passano i giorni, le settimane, compie lì i suoi 26 anni. Da soldato semplice diventa tiratore scelto. “Quanti? No, non ho mai parlato di queste cose. Non ne parlo. Non lo facevamo nemmeno tra commilitoni. Cosa pensavo? Quando avevo uno jiadhista nel mirino pensavo proprio ai miei compagni e al fatto che da quel momento in poi non avrebbe più ucciso nessuno di noi”.
(foto di Alec Cani)
Francesco Bellu