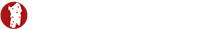Ancora qualche settimana di convalescenza per Stefano Marongiu, l’ infermiere sardo guarito dall’ebola, poi potrà tornare al lavoro e riprendere le abitudini normali. “Spero ai primi di luglio. Per ora sono ancora un po’ debole, ho bisogno di rimettermi in forma”.
Quello che ha passato negli ultimi tempi mesi non è un’esperienza che dimenticherà facilmente. Quattro mesi di lavoro intenso in Sierra Leone, nell’Ebola Treatment Center di Goderich, il rientro nella sua casa sassarese e infine il terribile responso: quella febbre alta, a pochi giorni dal ritorno, non era un’influenza e non era neanche malaria. Immediato il trasferimento a Roma, nel centro specializzato per le malattie infettive ‘Spallanzani’ dove già era stato curato un altro medico di Emergency, Fabrizio Pulvirenti, il ‘paziente zero’ di ebola.
Oggi Stefano Marongiu, 37 anni, sassarese, attende di tornare al suo impiego come infermiere specializzato al 118 di Sarroch. Nel frattempo legge (ha appena terminato ‘Zona rossa’ di Gino Strada e Roberto Satolli proprio su ebola in Africa), fa lunghe passeggiate per rimettere in sesto la muscolatura, sta con la famiglia e gli amici. Quella di oggi a Cagliari è la prima trasferta dopo la guarigione: sarà alla Fiera di Cagliari per il quattordicesimo incontro nazionale di Emergency, l’organizzazione non governativa con cui ha scelto di collaborare, parteciperà all’appuntamento delle 17 in cui si parlerà proprio di ebola in Africa.
Marongiu, ha trascorso quattro mesi in Sierra Leone a contatto con malati di ebola. Ha idea di quale sia stato il momento del contagio?
Ho cercato di ricostruire le ultime settimane per cercare di ricordare ma no, non ho trovato nessun episodio significativo. E quando sono partito per rientrare a casa ero totalmente tranquillo: se avessi avuto il minimo dubbio su un eventuale contagio non sarei salito su un aereo, non avrei messo a rischio gli altri, i miei amici e la mia famiglia.
Dicono che si è trattenuto a Roma per due giorni, che il suo viaggio poteva essere rischioso per gli altri passeggeri.
Nessun rischio: il virus è contagioso solo dopo che si manifesta la febbre, e infatti quando sono partito da Freetown mi hanno misurato la temperatura per tre volte in aeroporto, poi mi hanno controllato ancora negli aeroporti di Casablanca e Roma: stavo bene e non avevo nessun sintomo. Ho iniziato a sentirmi strano la domenica notte, due giorni dopo l’arrivo a Sassari: senza avere la certezza di quello che mi stava succedendo mi sono chiuso in camera e ho chiesto ai miei familiari di non entrare. Lunedì mattina ho misurato la febbre, avevo 39,2, a quel punto ho dato tutte le disposizioni per escludere il contatto con gli altri, ho allertato la Asl e si è messa in moto la procedura di emergenza. Fino all’ultimo ho sperato che fosse malaria ma ero consapevole che poteva trattarsi di ebola. E, come sappiamo, è andata così. Da qui è partita una macchina straordinaria che ha coinvolto tante persone diverse fino al mio arrivo allo ‘Spallanzani’ di Roma.
Cosa ricorda del ricovero?
Durante il viaggio mi hanno dato dei farmaci, quindi sono arrivato a Roma in stato di vigilanza alterata, aumentato anche dallo stato virale. Poi sono stato un po’ meglio e dopo c’è stato un peggioramento, ma è il corso normale della malattia. Quello che ricordo è che in queste quattro settimane di isolamento completo non mi sono mai sentito veramente solo: non potevo ricevere visite ma ho sentito tante persone accanto e potevo comunicare tramite telefono e messaggi. A volte mi collegavo via Skype anche con i miei colleghi rimasti in Sierra Leone. Erano con me la mia famiglia, i miei amici, quelli dello Spallanzani a cui leggevo negli occhi il desiderio di aiutarmi. Ecco, è un bellissimo esempio di eccellenza italiana, messo in piedi dall’incontro tra una organizzazione non governativa e la sanità pubblica. E poi c’è sempre stata la grande, meravigliosa famiglia di Emergency attorno a me.
Ci sono stati dei momenti in cui ha pensato di non farcela?
Purtroppo quando conosci la malattia, hai avuto davanti pazienti e casistiche a quel punto hai la percezione di quello che potrebbe accaderti. Si, ho pensato di non farcela: in quei momenti capivo sulla mia pelle tutto quello che avevo visto in Sierra Leone. Però sapevo che i medici e tutte le persone attorno a me avrebbero fatto di tutto per farmi guarire.
Il momento più doloroso?
Salutare mia mamma e le mie sorelle da lontano, con un semplice gesto della mano, come si faceva in Sierra Leone per evitare il contatto con pazienti e persone a rischio.
Cosa ha provato quando le hanno detto ‘è finita, si torna a casa’?
Incredulità, enorme. E paura: il timore più grande era tornare in contatto con familiari e amici credendo di poter essere ancora pericoloso. Ovviamente una paura irrazionale, non mi avrebbero mai permesso di uscire se non fossi stato completamente guarito.
E adesso?
Ora si torna alla vita normale: rientrerò al lavoro tra qualche settimana, poi andrò di nuovo allo ‘Spallanzani’: mi hanno chiesto di collaborare con loro per combattere ancora ebola, il mio sangue potrà essere utile per curare altri pazienti e studiare nuove terapie.
Francesca Mulas