“Spesso i tagli a raso rappresentano l’inizio della desertificazione”. Se l’Ente foreste difende a testa bassa il progetto di radere al suolo 550 ettari di lecceta del Marganai (su un totale di circa 2.300 ettari), l’Accademia di Scienze forestali di Firenze ha qualche serio dubbio. L’iniziativa è nota: aprire le porte alle motoseghe che il poco più di un decennio dovrebbero tagliare a raso una superficie vasta quanto 450 campi da calcio. Per due motivi principali: ricavarne legna da ardere e materia prima per la produzione di pellet.
I cugini del taglio a raso: erosione, desertificazione, dissesto
Sul tema, a differenze dell’Ente foreste, il vicepresidente dell’Accademia di Scienze forestali Raffaello Giannini qualche domanda in più se la pone. “Il tema è noto, anche grazie a una bibliografia corposa. Gli effetti del taglio a raso risultano decisamente negativi soprattutto se attuati su suoli in pendenza, in clima caldo-aridi e su vaste superfici”, dice Giannini, quasi a fotografare la situazione del Marganai. Ma quali sono questi effetti negativi? In particolare, essi riguardano “l’humus, l’erosione del territorio, il degrado e il dissesto delle aree”. Di più: “Spesso, è l’inizio della desertificazione”. È il caso del Marganai? Il team di esperti che sta aggiornando il Piano di gestione dell’area SiC Marganai-Monte Linas, tra i quali figura Angelo Aru, uno dei padri della geopedologia in Sardegna, è giunto a una conclusione molto semplice: “I tagli? Nefasti”. Qui il fotoreportage realizzato da Sardinia Post pochi mesi fa.
Prescrizioni rispettate?
Per limitare i danni pur consentendo la ceduazione, “non a caso – aggiunge il vicepresidente dell’Accademia – le amministrazioni pubbliche responsabili della gestione del territorio hanno emanato normative che, pur accettando un compromesso sull’utilizzazione boschiva, permettono i tagli a raso ma con limiti operativi tra cui l’età del soprassuolo e l’estensione della tagliata. Tale normativa, credo, sia in vigore anche in Sardegna”. E infatti così dovrebbe essere almeno nei SiC, i Siti di importanza Comunitaria. Ad esempio, le prescrizioni prevedono che non si possano superare i 10 ettari. Lo ha ricordato anche il professor Pulina. Peccato che nel caso del Marganai, in alcuni casi si sia arrivati anche a 16 ettari senza soluzione di continuità.
Miliardi pubblici spesi per preservare un patrimonio che ora si vuole impoverire
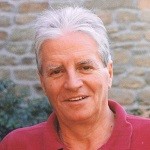
C’è poi un altro aspetto della vicenda finora poco approfondito. “Ci si è posti un altro interrogativo? E cioè: il Progetto pilota getta o potrebbe gettare le basi per dare il colpo di grazia alla politica (che spero prosegua) perseguita fino ad ora con immani sforzi di lavoro e di denaro per quasi un secolo, e finalizzata al miglioramento degli ecosistemi forestali di proprietà pubblica, ovvero quelli gestiti dall’Ente foreste e che sono patrimonio di tutti i Sardi?”. Certo, fa un po’ specie pensare che l’area del Marganai fu acquistata dall’Azienda foreste demaniali (poi diventata Ente foreste) nel 1979, dietro il pagamento di oltre un miliardo di lire con l’obiettivo di preservare il territorio, e che oggi ci si arrischi in un’operazione che comporta parecchie incognite. “Penso che si dovrebbero spiegare bene le motivazioni e le valutazioni di ordine economico-finanziario che sono state essere poste alle base del Progetto – dice Giannini – perché gli aspetti economico-finanziari e quindi le scelte gestionali correlate, non appaiono sempre convincenti anche perché spesso si dimentica o si sottovaluta il fatto che per realizzare un nuovo soprassuolo occorrono gli stessi anni dell’età di quello che viene utilizzato, ma, forse, qualcuno di più”.
Correzioni in corsa. Che l’Ente non prende nemmeno in considerazione
Conclude Giannini: “I ‘Progetti pilota’ spesso vengono redatti per definire progetti di più vasta portata (in effetti, il progetto pilota comportava l’abbbattimento di 330 ettari, poi saliti a oltre 550 con il Piano di gestione, ndr). La cosa solleva qualche perplessità, però è peccato fare il processo all’intenzione anche se qualche volta ci si azzecca. Speriamo che se si evidenziassero errori, vi sia la possibilità di apportare correzioni e di non farli divenire definitivi. Ho letto con attenzione su Sardinia Post l’intervento del Prof. Pulina, Prof.ordinario del settore Zootecnico dell’Università di Sassari, e non mi sembra prenda in considerazione questa possibilità”.
Il ruolo dell’assessore regionale all’Ambiente
“In Sardegna – conclude Giannini – avete la fortuna di avere un assessore all’Ambiente (Donatella Spano, ndr) con un curriculum di esperienza nel settore dell’ecologia applicata quindi interprete sicuro delle politche di salvaguardia ambientale e penso, ad esempio, conoscitore del significato conservativo, ma non solo, dei siti SiC. La domanda che potreste rivolgere è: a chi giova ciò?”. Sarà il prossimo passo di questa lunga inchiesta.
Pablo Sole







