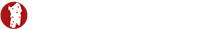Oggi è un paradiso per turisti dalla natura selvaggia ed incontaminata, giustamente eletto a Parco Nazionale e Area Marina Protetta. Ma già all’arrivo nel piccolo approdo di Cala Reale si comprende che, per secoli, questa piccola isola ad un tiro di schioppo da Stintino è stato un inferno.
La riscoperta dell’album intitolato “I prigionieri di guerra austriaci all’Asinara. 18 dicembre 1915-24 luglio 1916”, conservato all’Archivio centrale dello Stato e pubblicato a cura di Assunta Trova e Giuseppe Zichi, con analisi delle immagini di Salvatore Ligios, lo conferma e contribuisce a ricostruire un episodio buio e prontamente rimosso dalle cronache della Grande Guerra, passato alla storia come “i dannati dell’Asinara”.
L’album, pubblicato da EDES Editrice Democratica Sarda col titolo “Asinara, isola piccola Grande Storia – Prigionieri e Profughi della Prima Guerra Mondiale” (in distribuzione a breve) si compone di 51 fotografie, 11 fra piantine, mappe e cartine, grafici e disegni. Il materiale originale è in mostra a Sassari, dal 27 ottobre, presso i locali del dipartimento di Scienze Politiche dell’Università in viale Mancini.
Nota soprattutto per le vicende recenti del Supercarcere in realtà “ Fin dal 1885 — scrivono gli autori — l’Asinara venne considerata alla stregua di un luogo nel quale lo Stato poteva esercitare ogni sorta di diritto. Cacciata l’intera popolazione (qualche centinaio di individui), vi venne così creata una stazione internazionale di quarantena marittima, destinata ad evitare la diffusione di malattie contagiose, e contemporaneamente una colonia penale agricola all’aperto. Per gli abitanti dell’isola non ci furono le contropartite attese”. Un’abitudine, quella delle servitù e dell’uso spregiudicato, da parte dei militari, del nostro territorio che ha radici antiche.
L’episodio, che i documenti ritrovati aiutano a descrivere, fa parte della storia della prima guerra mondiale. Le vicende belliche portarono alla cattura, da parte dei serbi, di circa 60.000 prigionieri austro-ungarici. Un numero impressionante ingestibile nei campi di prigionia di quello stato. Questo costituiva un grosso problema da risolvere in fretta. L’Italia, che mirava ad assicurarsi un ruolo guida nei Balcani, riuscì a farsi assegnare la gestione dell’emergenza, salvo poi dimostrarsi del tutto impreparata ad amministrare in maniera adeguata il problema.
Infatti ad ondate successive e in sole otto settimane 24.000 prigionieri raggiunsero la piccola isola dell’Asinara. Altri sbarcarono nelle settimane successive. Più di 1.500 uomini morirono durante il viaggio, molti altri arrivarono stremati e già segnati dalle malattie. Era l’anno1916 e in sole due settimane morirono più di 1.300 prigionieri per arrivare a 7.000 decessi nei primi tre mesi di prigionia.
Le testimonianze storiche raccontano di un’isola con strutture largamente insufficienti ad accogliere una così imponente popolazione, sferzata dal gelido maestrale e con una cronica penuria d’acqua potabile. Questi disperati, già provati dalla guerra, dalla fame e dalle malattie vennero ammassati dentro rifugi di fortuna, in precarie condizioni igieniche, facilitando in tal modo il diffondersi dell’epidemia di tifo e di colera che non risparmiò nemmeno i loro carcerieri.
Le foto ritrovate, che sembrano degli “Autochrome” (tecnica che si andava diffondendo in quegli anni) o, come ipotizza Salvatore Ligios, originali in bianco e nero acquerellati a mano lasciano solo vagamente intuire il dramma che si svolse nella piccola isola. “La messa in posa – si chiede Ligios nella sua analisi delle immagini – era una libera scelta del fotografo oppure l’esecuzione di un ordine del superiore militare o del responsabile sanitario? Il fotografo era un libero professionista o un militare addetto alla documentazione ufficiale? Che fine hanno fatto gli scatti che non sono entrati nella selezione?”.
Condivido con lui il sospetto che quelle immagini registrassero solo la realtà presentabile, controllate com’erano dalla censura militare che, già dalla guerra in Crimea, aveva messo a punto le strategie di comunicazione. E’ infatti emblematica la storia del fotografo Roger Fenton, inviato dal governo britannico nella carneficina dell’assedio di Sebastopoli. Fenton, considerato il primo vero fotografo di guerra, ebbe dai militari pochi e chiari ordini: non fotografare i morti, i mutilati e gli ammalati. Possibilmente ritoccare le foto perché rappresentassero una realtà di comodo. Così — scrisse Susan Sontag — “Fenton si limitò a rappresentare la guerra come una dignitosa scampagnata per soli uomini”.
Anche le foto dell’album paiono non sfuggire alla regola della messa in posa studiata per rappresentare un’apparente e rassicurante normalità. Solo l’elenco dei morti, scrupolosamente compilato, dà conto dell’orrore della vicenda. Ma se non ci limitiamo a guardare quelle immagini dal delicato stile pittorico, se le osserviamo con occhio critico e con il conforto della storia, vedremo che, anche cercando di tenete distante la morte e la sofferenza con inquadrature in campo lungo, il fotografo riprende particolari rivelatori, come le tendopoli dove, in pieno inverno, erano stipati i prigionieri.
E veniamo ai giorni nostri dove, fatte le debite eccezioni, resta immutata la tentazione di manipolare l’informazione. Le immagini della guerra del golfo (e non solo quelle) sono state rigidamente controllate dagli stati maggiori americani che ci hanno propinato rappresentazioni di bombardamenti notturni che sembravano uscire da una playstation. Niente morti, case distrutte, civili in fuga ma solo immagini di repertorio, decolli e atterraggi sulle portaerei condite con il continuo panegirico delle cosiddette bombe intelligenti. E’ la storia di Roger Fenton che si ripete.
Le immagini della realtà sono state scattate dai pochi operatori freelance, sfuggiti al controllo dei militari, che hanno rischiato la vita per raccontare qualcosa di vero. Ma, ironia della sorte, le immagini più crude e sconvolgenti e rivelatrici di quella guerra ce le hanno inconsapevolmente fornite proprio loro, i militari. Sono le “foto ricordo” delle torture nel carcere di Abu Grahib.
Enrico Pinna